
CHI HA PAURA DEL REDDITO DI CITTADINANZA?
È arrivata una nuova sparata sul cosiddetto “reddito di cittadinanza”: diamo i fondi alle imprese che li utilizzeranno per formare il personale da assumere, sostanzialmente tenendoli in prova per il tempo di fruizione del sussidio. Cioè? Le aziende avrebbero per 2 anni personale retribuito dallo Stato? E quindi o sottopagato rispetto al ruolo o impiegato ad orario parziale. E di che natura sarebbe il rapporto?
Ci sono già istituti per l’inserimento in azienda di un lavoratore: uno spesso abusato, il tirocinio, uno sottoutilizzato, l’apprendistato. E quindi il senso di questa proposta?
Qualcuno potrebbe pensare che così ci sarebbe la certezza che i lavoratori disoccupati riceverebbero la formazione che serve in azienda e sarebbero assunti. Quindi l’azienda dovrebbe impegnarsi all’assunzione all’inizio del percorso? E a quali bisogni professionali risponderebbe l’inserimento del lavoratore? Quelli rilevati (o percepiti?) al momento dell’inizio del percorso o quelli previsti alla sua conclusione? Ci vorrebbe un progetto formativo? Chi garantirebbe la valenza formativa del percorso e la congruità della sua durata? E le aziende si scoprirebbero improvvisamente vocate alle assunzioni e alla cura della formazione del personale assunto, vocazione finora che non pare così largamente diffusa. E insomma: le domande potrebbero ancora moltiplicarsi.
Ci sono altre argomentazioni sulle quali in parte ci troviamo costretti a ripeterci: la famigerata curva di Beveridge per l’Italia. Il tasso di posti vacanti a livello nazionale è intorno ad un decimo del tasso di disoccupazione. Quindi i bisogni professionali attuali delle aziende non coprirebbero che un decimo dei disoccupati. In che modo i percorsi aziendali di questa reinterpretazione del reddito di cittadinanza si inserirebbero in questo contesto? È presumibile che i beneficiari della misura non siano esattamente i lavoratori più appetibili da parte delle imprese, i più occupabili.
E in un contesto in cui il rapporto tra posti vacanti e tasso di disoccupazione è più sfavorevole la soluzione ipotizzata sarebbe ancora meno praticabile. Ci sono aree, regioni, in Italia in cui si registra un tasso di disoccupazione più che doppio rispetto alla media nazionale. Per non parlare del tasso di occupazione e di inattività. La misura potrebbe portare una quota di inattivi a porsi almeno formalmente in cerca di un’occupazione, transitando così tra i disoccupati e peggiorando il rapporto tra posti vacanti e persone in cerca di lavoro.
Appare quindi necessario porsi il problema del significato reale della misura e degli obiettivi realistici che può porsi. Anche qui ci tocca ripeterci, citando il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, che ha appena compiuto un anno e che nelle intenzioni delle istituzioni della UE dovrà permeare le politiche europee e degli stati membri nei prossimi anni. Si tratta di 20 principi cardinali.
Il principio 14 recita:
Minimum income
Everyone lacking sufficient resources has the right to adequate minimum income benefits ensuring a life in dignity at all stages of life, and effective access to enabling goods and services. For those who can work, minimum income benefits should be combined with incentives to (re)integrate into the labour market.
In italiano:
Reddito minimo
Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.
E quindi è il caso di dire che la misura “ce la chiede l’Europa”.
Potremmo dire che la misura è una misura indispensabile di redistribuzione dei redditi a difesa del patto sociale, messo a rischio dall’evoluzione del mercato del lavoro, particolarmente critica in Italia. Questo non vuol dire che la misura debba consistere esclusivamente in una forma passiva di sostegno al reddito, né chi l’ha proposta già nel 2013 l’ha mai pensata così. Date le condizioni effettive del mercato del lavoro, le linee strategiche per conferire una natura attiva all’impianto del reddito di cittadinanza non possono limitarsi ad un mero rilevamento dei bisogni delle aziende hic et nunc, qui ed ora, perché altrimenti al massimo si potrebbe puntare a coprire quella quota di posti vacanti scarsamente rilevante nell’ottica dell’aumento del tasso di occupazione e in Italia già al di sotto di un livello fisiologico normale. Quindi bisogna alzare lo sguardo e puntare ad un orizzonte più ampio.
Il grande obiettivo di fondo è creare lavoro. E questo non si fa con i centri per l’impiego. Si fa con le politiche industriali, con le politiche di sviluppo sostenibile (coerenti con Agenda 2030 dell’Onu, che ha già compiuto 3 anni, che impegna tutti i paesi Onu al raggiungimento di 17 macro obiettivi interconnessi, tra i quali il contrasto alle diseguaglianze e il lavoro dignitoso per tutti), la ricerca, l’innovazione, e via declinando. Sulle persone in cerca di lavoro, sui lavoratori bisogna intervenire in termini di occupabilità, di sviluppo delle competenze, anticipando i bisogni professionali, che non corrispondono esattamente a quello che percepiscono le aziende e che possono comunicare in questo momento ad un “analista” attraverso qualcosa di molto simile ad una telefonata. Vanno sviluppate e manutenute quelle competenze che consentono agli “umani” di non essere sostituibili dalle macchine, competenze in continua evoluzione, guardando al paradigma di quello che qualcuno ha già cominciato a chiamare Industry 5.0, nel quale le macchine non eliminano gli umani dai processi produttivi ma ne potenziano le capacità.
C’è poi l’aspetto dell’autoimpiego, della creazione d’impresa, del lavoro autonomo in tutte le sue declinazioni, anche ibride. È un meccanismo non secondario per la fuoriuscita dallo stato di disoccupazione, come è noto, soprattutto nelle aree in ritardo di sviluppo. Difficile pensare di poterlo coniugare affidando esclusivamente le risorse alle aziende nell’ottica di un lavoro subordinato. È comunque certo che le imprese esistenti hanno e avrebbero comunque un ruolo centrale. Le nuove imprese, il lavoro autonomo non possono nascere e crescere come isolati cactus in un deserto: è necessario favorire e fertilizzare un ecosistema che ne consenta lo sviluppo in una logica di rete.
A chi fa paura tutta questa ineluttabile complessità, al punto di semplificarla a soluzioni da circolo della briscola?
Paolo La Carrubba
Presidente di Itinerari per il Lavoro
chi_ha_paura_del_reddito_di_cittadinanza.pdf
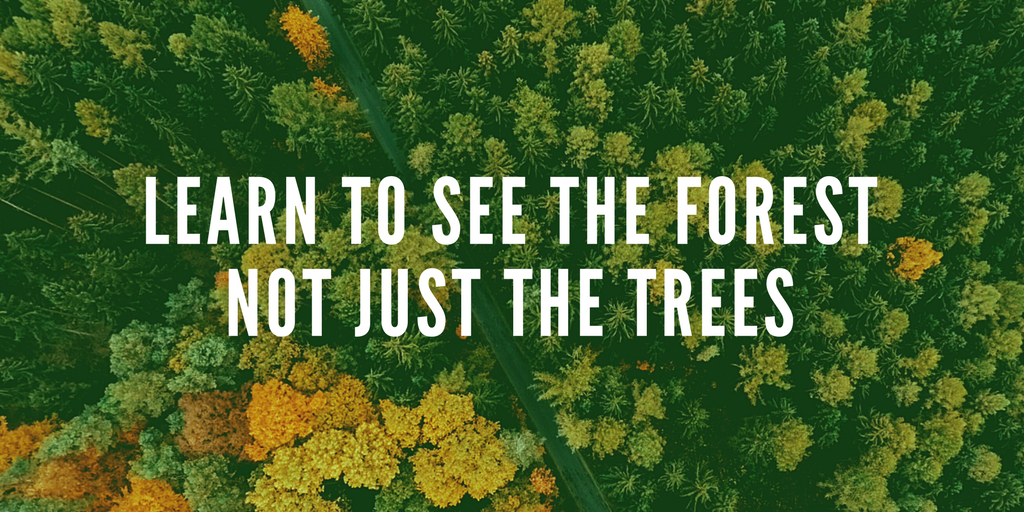
| Print article | This entry was posted by Itinerari on 24.11.2018 at 09:32:00 . Follow any responses to this post through RSS 2.0. |



